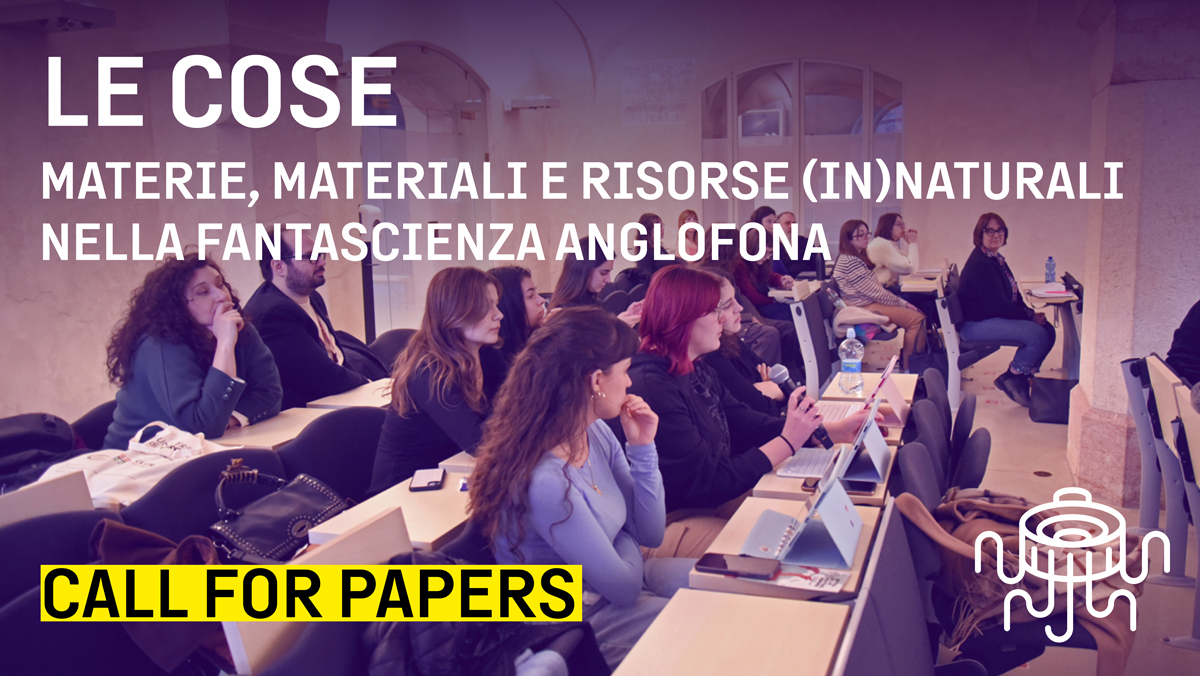
Quando si pensa alla fantascienza, si immaginano spesso mondi lontani e fantastiche invenzioni senza interrogarsi su che cosa supporti l’esistenza materiale di questi mondi e degli esseri che li abitano. Che carburante propelle le navicelle spaziali di Battlestar Galactica? Chi tiene le luci accese nel post-apocalisse? Che materie immaginarie ed elementi (in)naturali compongono i mondi altri? Negli universi narrativi più complessi, queste risposte sono spesso disponibili (in Battlestar Galactica, ad esempio, il carburante è il Tylium) e talora di centrale importanza per la trama. Ciò nonostante, limitata attenzione critica è stata rivolta alla materialità della fantascienza. Dalla spezia di Dune (1965) agli alieni-cristallo di Theodore Sturgeon (Cristalli sognanti, 1950), dagli asteroidi senzienti (Il vagabondo dello spazio di Fredric Brown, 1957) al vibranio dell’universo Marvel, dalla terraformazione di pianeti (ad esempio nella Trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson, 1993-1996) allo sfruttamento di risorse più o meno realistiche (Il mondo della foresta di Ursula K. Le Guin, 1972), la materia diventa protagonista insieme ai personaggi, influenzando società, economie e conflitti.
La giornata di studi “Le cose. Materie, materiali e risorse naturali nella fantascienza anglofona” intende approfondire il ruolo dei materiali e delle risorse (in)naturali nei mondi della fantascienza intesa in senso lato, con attenzione alla loro dimensione simbolica, narrativa, ecologica e politica. L’evento si propone di accogliere contributi interdisciplinari provenienti da letteratura, cinema, media digitali, studi culturali e scienze naturali, con l’obiettivo di comprendere come la fantascienza utilizzi la materia per costruire mondi coerenti, eticamente complessi e narrativamente ricchi.
Negli ultimi anni, l’ambito umanistico, specie nell’ecocritica, ha assistito a un “elemental turn” che sottolinea l’agency degli elementi naturali e dei materiali non umani nelle pratiche culturali e narrative. Studi recenti come quelli di Moritz Ingwersen e Timo Müller (“The Aesthetics and Politics of Elemental Agency,” 2022) e precedentemente di Jeffrey Jerome Cohen e Lowell Duckert (Elemental Criticism, 2015) hanno evidenziato come aria, acqua, terra e fuoco non siano semplici sfondi della narrazione, ma agenti capaci di influenzare trame, conflitti e configurazioni sociali. Il nebuloso campo della geopoetica dimostra la forte correlazione tra la materia-mondo e l’arte (si veda Leeuw e Magrane, “Geopoetics,” 2019). Gli studi letterari sull’estrattivismo (si veda Imre Szeman e Jennifer Wenzel, “What Do We Talk About When We Talk About Extractivism?”, 2021) ne sottolineano la pervasività all’interno del sistema culturale (tardo) capitalista. La fantascienza, con la sua libertà immaginativa, offre un terreno privilegiato per esplorare queste prospettive.
La giornata di studi accetta proposte sui seguenti temi:
Invio delle proposte
Invitiamo studios* e artist* a proporre interventi originali di circa 15 minuti che approfondiscano uno o più dei temi sopra indicati, presentando analisi testuali, cinematografiche o multimediali, riflessioni teoriche o casi di studio interdisciplinari.
Le proposte dovranno includere un abstract di massimo 300 parole e un breve profilo biografico (150 parole).
Scadenza per l’invio delle proposte: 30 novembre 2025
Modalità di invio: via mail a chiara.battisti@univr.it; serena.demichelis@univr.it; beatrice.melodiafesta@univr.it; valentina.romanzi@univr.it.
Le notifiche di accettazione saranno inviate a metà dicembre.
Il convegno, grazie al sostegno del Dipartimento di Lingue e letterature straniere dell’Università di Verona, sarà gratuito e aperto al pubblico.
Cliccate qui per la call in pdf.
Ricevi aggiornamenti